Giorgio Gaber nel 1969 pubblicava una canzone intitolata “Come è bella la città”. Il testo, dal tono sarcastico, forse perché in opposizione a Celentano che tre anni prima cantava la via Gluck, poneva uno sguardo critico sulla frenesia di una Milano già in fase di accelerazione, ma conteneva, come in ogni sarcasmo d’autore, un fondo di verità: un amore e una passione per la città, luogo privilegiato della vita e dell’allegria.
Milano, ai tempi dell’emergenza, è strutturalmente e funzionalmente diversa da quella che rimpiangeva e derideva Gaber. La chiusura dei negozi, il divieto di assembramenti e addirittura di riunioni appena numerose rendono le nuove misure straordinarie molto simili a quello che potremmo chiamare coprifuoco, in cui sembrano mancare solo l’ordine di oscurare le finestre e il divieto di parlare di politica.
E se da un lato la cautela e le misure di precauzione sono la migliore tutela dei soggetti più deboli, il rischio di veder scomparire, in nome dell’emergenza, alcune o molte delle libertà fondamentali che trovano realizzazione nella città è piuttosto elevato.
L’anno precedente alla canzone di Gaber, nel 1968, Henri Lefebvre pubblicava a Parigi “Il diritto alla città”, ed affermava in modo dirompente che “la città ha senso solo come opera, come fine, come luogo di libero godimento, come campo del valore d’uso.
La forma dell’urbano, la sua ragione suprema, cioè la simultaneità e l’incontro, non possono sparire. L’urbano [deve essere] luogo del desiderio, squilibrio permanente, sede della dissoluzione delle cose normali e dei contrasti, momento del divertimento e dell’imprevisto, fino all’intasamento-esplosione della violenza latente.” (H. Lefebvre, Diritto alla Città, Marsilio, 1970, prima ed. italiana).
Simultaneità e incontro rappresentano una pregevole sintesi della qualità primaria (suprema la chiama Lefebvre) dell’urbano. La definizione, in sole due potentissime parole, racconta del perché la città sia luogo privilegiato dello stare insieme, territorio dell’incontro, dello scambio, del divertimento creativo, della dinamica educativa, del conflitto, e così via… Quando vengono meno queste due caratteristiche, potremmo dire che viene meno l’elemento costitutivo della città, e di fatto la città si trova ad essere molto meno … città.

La città immaginata e invocata da Lefebvre è un movimento, una contraddizione, un impeto dinamico e in veloce trasformazione in cui la demolizione di ogni sovrastruttura è sostituita da “l’immaginario che si investe nell’appropriazione del tempo, dello spazio, della vita fisiologica, del desiderio”.
Il filosofo francese, osservando la città di Parigi prima del ‘68, scrive righe rivoluzionarie, impregnate di una forza anarchica e gioiosa, in cui chiede a gran voce di “smetterla con la separazione tra “quotidiano e tempo libero” o “vita quotidiana – festa”. Bisogna ricostituire la festa trasformando la vita quotidiana. La città è stato spazio occupato tanto dal lavoro produttivo quanto dalle opere, dalle Feste.”
Per Lefebvre “il diritto alla città si manifesta come forma superiore dei diritti, diritto alla libertà, alla individualizzazione nella socializzazione, all’habitat e all’abitare.”
Pochi anni prima sia di Gaber sia di Lefebvre, Jane Jacobs pubblicava il testo fondamentale per l’indagine sociologica urbana, “Vita e morte delle grandi città”, ponendo nuove basi della disciplina urbanistica. Per la prima volta venivano sistematizzati l’osservazione e lo studio della vita reale, uniti all’analisi dei comportamenti eterodossi (contrapposti all’ortodossia di una scienza urbanistica fortemente codificata), una metodologia colma di grande misura umana, in cui l’organismo concreto della città e di tutti gli abitanti valeva piú delle regole astratte e delle norme codificate.
La Jacobs percorreva passeggiando i marciapiedi di Brooklyn e del Bronx, e osservava l’incredibile vitalità di una città vista e vissuta dal basso, composta da residenti, piccoli commercianti e artigiani, servizi di quartiere, flaneurs, tutti a formare una comunità tanto forte quanto inconsapevole, capace di solidarietà, umanità, coesione e dispensatrice di una diffusa forma di sicurezza ben prima che il concetto di rispettabilità (messa in crisi dalla famosa finestra rotta) rovinasse tutto: “Condizione essenziale … è che lungo i marciapiedi dei quartieri sia disseminato un congruo numero di negozi e di altri luoghi pubblici, e in particolare di esercizi e luoghi pubblici frequentati nelle ore serali e notturne … possono favorire in modi diversi e complessi la sicurezza dei marciapiedi”.
L’attacco della Jacobs a quello che oggi chiamiamo “decoro” si sviluppa attraverso una consapevolezza che deriva dall’esperienza: “sotto l’apparente disordine delle vecchie città esiste – dovunque la città adempie con successo la sua funzione – un meraviglioso ordine che può mantenere sicure le strade e al tempo stesso rendere libera la città. E’ un ordine complesso, la cui essenza risiede nella fitta mescolanza di usi … e ciascun posto è sempre ricco di nuove improvvisazioni”.
Jane Jacobs, profeticamente, quasi sessant’anni fa vincolava il disordine urbano, cioè quello che molti oggi chiamerebbero mancanza di decoro, ai concetti fondamentali di sicurezza e di libertà, attuate simultaneamente attraverso la mescolanza di usi e l’improvvisazione.
Si potrebbe affermare che la città garantisce la propria essenza e il diritto a se stessa solo se è libera, e se rende liberi tutti i cittadini.

Le riflessioni degli ultimi anni sul Diritto alla città, eredità di Lefebvre e della Jacobs, hanno prodotto molta letteratura e quindi molte pubblicazioni riguardo al Diritto, o per meglio dire ai diritti. Crediamo sia interessante – in questa fase di profonda crisi urbana – parlare e ragionare del concetto di città, da un punto di vista radicale, associato a quello del diritto.
La riflessione sulla città ai tempi dell’epidemia non può prescindere dall’immaginare quale sarà la realtà urbana “dopo” l’epidemia, e la domanda su cosa ne sarà dei diritti fondamentali – tra cui bene sommo, come detto, è il diritto alla città – non può essere elusa.
Il rischio di cui parliamo, evidente già fin da prima dell’epidemia virale, era di trovarci ogni giorno sempre più immersi – e in modo inconsapevole – nella società del controllo globale, sotto il domino del dato totale e dell’algoritmo che segue ogni passo, ogni azione, fino ad anticipare ogni volontà.
Con l’entrata in vigore dei nuovi Decreti, sicuramente finalizzati alla riduzione del danno provocato dall’epidemia (ma di questo argomento non si vuole parlare qui) si aggiunge un nuovo pericolo, più insidioso perché non si palesa nell’immediato ma si configura come conseguenza lontana nel tempo futuro di decisioni prese oggi.
La città è tale perché in essa si vive la simultaneità tra un gran numero di soggetti, perché è luogo dell’incontro tra soggetti profondamente e radicalmente diversi, perché è il luogo del conflitto, e perché in forma imperfetta e parziale tenta di garantire il diritto alla città.
Questo diritto – fondamentale – è quello che dovrebbe garantire ad ogni cittadino, ma soprattutto a coloro che non fanno parte delle élites, luoghi pubblici in cui esercitare il libero godimento della città, servizi pubblici essenziali alla vita quotidiana, sicurezza urbana garantita da rapporti di vicinato liberi e creativi, mescolanza di funzioni e di usi dello spazio…
La città del virus rischia di cambiare la propria forma. Rischia di trasformarsi, in nome dell’igiene e della salute pubblica, in un enorme contenitore asettico e anonimo, in cui elementi essenziali quali la forma disordinata della festa e del mercato, la ribellione data dall’uso creativo e non convenzionale degli spazi, vengono spazzate via da due decreti e dal silenzio imposto per legge.
La chiusura di tutto il sistema sociale serale e notturno non è solo la chiusura della movida o delle apericene (che forse si meritavano questa fine) ma significa la chiusura dei teatri, il silenzio della musica, l’oscuramento dei cinema, e così via.
La crisi sta già colpendo duramente tutto il complesso mondo dei precari, dei contratti deboli, dei soggetti ricattabili, di coloro che non godono delle tutele “novecentesche” del contratto a tempo indeterminato.
Ma nella Milano della rendita, in cui ogni metro quadro deve produrre un reddito elevato, immediato e obbligatorio, la crisi dettata dal coprifuoco colpirà tanti piccoli negozi, tanti commercianti al dettaglio, tante iniziative intermedie di piccole dimensioni che si troveranno stretti tra l’affitto, i fornitori, le bollette, qualche stipendio e le esigenze dello stato.
Evidentemente non si tratta di difendere banalmente il commerciante di piccole e medie dimensioni, dimenticando i classici e storici difetti di un settore che non brilla certo per solidarietà, ma di osservare che la crisi non darà alcun fastidio ai grandi centri commerciali, alla mega GDO, ai giganti della distribuzione e del divertimento. Esselunga, Mediaworld, solo per fare due esempi, non subiranno contraccolpi; il bar e il negozietto sotto casa purtroppo sì.
Il diritto alla città, per un gran numero di soggetti in difficoltà che ancora abitano e rendono viva la città, passa attraverso i mercati rionali, dove per andarci non serve l’automobile, passa attraverso la consuetudine del rapporto con le mille porte aperte del micro-commercio, che rendono permeabile l’interno con l’esterno delle vie e le trasformano in luoghi pieni di gente nonché spazio della consuetudine.
Il rischio “urbano” è quello di veder trasformare – velocemente e in nome dell’emergenza – strutture e funzioni della città in direzione di una concentrazione sempre più marcata, nelle mani di pochissimi soggetti, delle attività principali, e verso la desertificazione delle strade dove anche i negozi ora possono essere trasformati in ben più redditizi appartamenti.

Il diritto alla città è anche questo: il diritto ad avere a disposizione di tutte e di tutti una città che sia tale, aperta, libera, simultanea e dell’incontro, luogo della festa e del tempo libero che contaminano ogni attimo e ogni metro quadro.
La crisi del virus chiama tutte e tutti a pensare, agire e lottare fin d’ora perché la città dopo la peste sia disordinata, mix accogliente di ogni tipo di diversità, e per questo libera e sicura, e non scompaia in nome dell’igiene e dell’ordine imposto dall’alto.
Franco Fortini, in un articolo dell’aprile 1987 sul manifesto, si chiedeva quale fosse il significato della peste nel romanzo del Manzoni. E giungeva alla conclusione che fosse inevitabile utilizzare due livelli di lettura, uno più superficiale e uno più profondo.
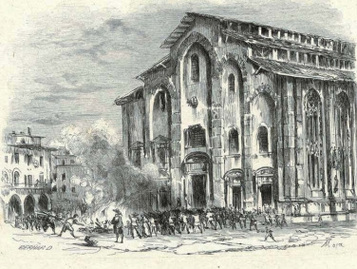
Secondo Fortini in un primo livello, quello più superficiale, Manzoni associava la peste alla Rivoluzione francese, “la figura storica che per tutta la vita lo aveva tanto più investito quanto meno ne aveva scritto”.
Indagando invece un livello più profondo, Fortini interpretava la visione manzoniana della peste come qualcosa di ben più forte, e pericoloso. Manzoni, sempre fedele ai valori democratico-borghesi di libertà e indipendenza, demonizza la peste e inconsciamente la associa ad un oggetto ben più temibile ai suoi occhi: “… la rivoluzione, ma non quella roberspierriana con la sua fede nella perfettibilità indefinita dell’uomo, bensì quella della rivolta agraria, di tradizione secolare, quella che deve divellere le pietre di confine della proprietà. La traduzione in italiano della rivoluzione francese appariva innanzitutto … la rivoluzione sociale, dunque della guerra civile: il disordine supremo.”
Quale migliore auspicio per la Milano al tempo del dopo-virus?


