Nella giornata di lunedì il governatore Fontana (contraddicendo quanto dichiarato dal segretario stesso del suo partito pochi giorni prima) ha annunciato, previo accordo con il ministro Speranza e il sindaco di Milano Sala, che da giovedì 22 e fino al 13 novembre sarà in vigore il coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5. La misura viene giustificata con il rialzo dei contagi e come “alternativa” a un nuovo possibile lockdown regionale, ma al tempo stesso la giunta leghista lo definisce un provvedimento “simbolico”.
A inizio epidemia avevamo pubblicato un contributo su ciò che non bisognava fare, a proposito di regionalizzazione, tagli e aziendalizzazione del sistema sanitario regionale (con il suo correlato di gestione manageriale della salute pubblica condivisa in modo trasversale agli schieramenti, e che adesso però illustri economisti della Bocconi sembrano scoprire come la proverbiale acqua calda).
Da marzo ad oggi il servizio sanitario non è corso ai ripari a livello organizzativo, non è stato potenziato ed oggi è nuovamente in crisi, a solo 10 giorni dall’inizio della seconda ondata. Non solo infatti si persegue il modello della centralizzazione ospedaliera in un contesto di immutata debolezza e fragilità del sistema sanitario regionale, ma le ATS dell’eccellenza lombarda si sono sostanzialmente dissolte con il crescere esponenziale del contagio; la capacità di tracciamento è saltata, anche a causa della mancata volontà del Governo di attuare piani più incisivi e di puntare tutto, di nuovo, sui comportamenti individuali e il potere salvifico dell’app Immuni, la quale però da sola anche con un tasso di download del 90% non sarebbe in grado di garantire il tracciamento e dunque il contenimento del contagio, senza un sistema sanitario territoriale forte: con 10-12.000 casi dovrebbe mandare 150.000-200.000 messaggi al giorno e l’attuale sistema non potrebbe semplicemente gestire una tale mole.
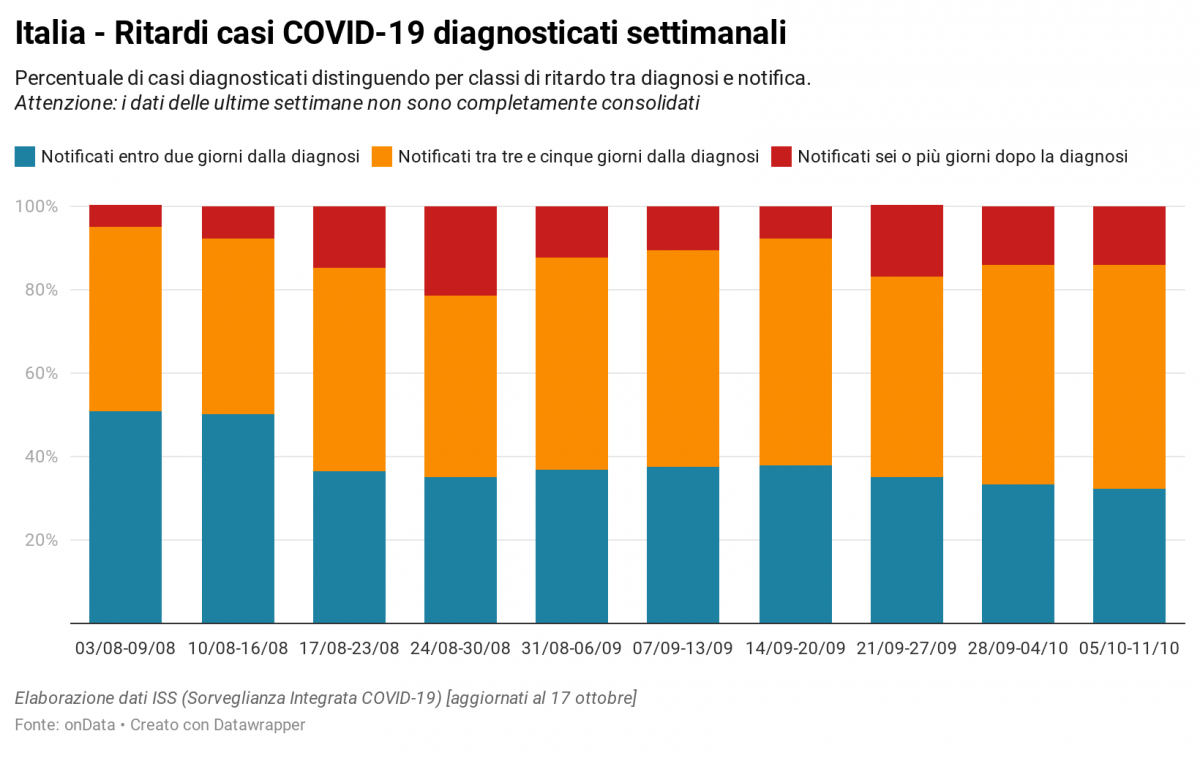
La cura però non è l’unico tassello utile al sistema per rispondere alle emergenze: si è parlato molto di prevenzione, sono stati firmati decine di protocollo anti Covid, come è possibile che in città il contagio sia esploso a dimensioni maggiori della scorsa primavera? Senza considerare l’assenza di un intervento sulla sanità territoriale negli ultimi 4 mesi – di cui abbiamo parlato pochi giorni fa -, prendiamo due altri piani centrali nel contrasto al contagio: la mobilità e il lavoro.
Considerando la Città Metropolitana di Milano, sul primo punto pesa il pasticcio di mancato rinforzo del trasporto pubblico locale (che ovviamente non è pensabile in soli 8 mesi – anche se c’è chi lo richiede da ben prima dell’epidemia -, ma questo costituiva un tempo sufficiente per indirizzare il sistema di mobilità) per cui si è pensato solo di ridurre all’80% la capienza (ovvero, considerando 1,4 milioni di viaggiatori ATM prima dell’epidemia, stiamo parlando comunque di 1,12 milioni di persone; a questi si aggiungono i 640mila di Trenord), abolendo la distanza di sicurezza e senza implementare le corse. Si poteva inoltre migliorare in superficie con maggior utilizzo di scuolabus e di nuovi mezzi, in particolare utili nelle ore di punta. Non è stato fatto. Al tempo stesso, l’incentivo all’utilizzo dei mezzi privati, ha reso ancora più congestionato il traffico per le linee tpl di superficie.

Per quanto riguarda invece il lavoro di sicuro i vari protocolli anti-Covid sul posto di lavoro hanno avuto più una funzione di scudo penale nei confronti delle responsabilità datoriali che di contenimento dell’epidemia.
Non possiamo dimenticare che, dopo il #milanononsifera di febbraio, il sindaco-manager aveva preteso il rientro al lavoro per chi era in smart working. Misura che deve essere accompagnata al mantenimento delle scuole aperte, ma che può e deve essere implementata per impiegati pubblici (14mila solo del Comune di Milano) per i quali è stato adottato il rientro in ufficio con la possibilità di smart working per un massimo di 6 giorni al mese, e lavoratori degli uffici, pendolari compresi, per cui lavoro e mobilità si intrecciano come rischi contagio.
Nell’ultima settimana nel Comune di Milano si è denunciato un numero in crescita di contagi che ha portato a un tavolo di trattativa conclusosi in un nulla di fatto, delegando di fatto la decisione al dirigente. Allo stesso modo, educatrici e educatori dell’infanzia hanno chiesto una diminuzione del rapporto numerico operatore-minori, data la crescita di classi in quarantena (per lo più fiduciaria, bisogna specificare) e l’elevato numero di luoghi comunali vuoti (pensiamo anzitutto alle caserme abbandonate e destinate ad altisonanti progetti di riqualificazione al momento fermi) e che si sarebbero potuti destinare a scuole e servizi educativi: anche in questo caso, non si sono volute accogliere le richieste delle lavoratrici e delle famiglie.
Infine, sempre sul tema lavoro, pesa il mantenimento a livello regionale dei grandi assembramenti lavorativi del lavoro logistico e industriale: dalle aree cantierizzate del bresciano per la TAV Brescia-Verona ai poli logistici del Mantovano, fino alla filiera produttiva e agroalimentare che si sviluppa lungo la A1 e che aveva già mostrato il suo carattere di luogo centrale dell’epidemia lombarda – dopo le RSA. Di fronte a tutto questo, chiediamo a Fontana, Sala e Speranza: a che gioco stiamo giocando con il coprifuoco notturno – che comunque non varrebbe per i lavoratori, ovvero per coloro i quali realmente si troverebbero in luoghi con alto assembramento, ovvero i luoghi di lavoro, in quella fascia oraria?



